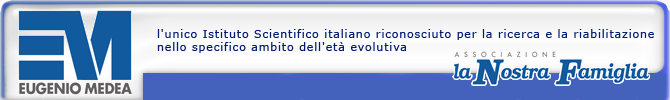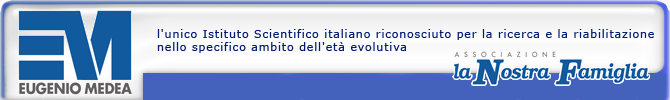|
Sordità
infantile. Aspetti epidemiologici ed eziologici
D. Soi – D. Brambilla
La sordità è il più comune deficit
sensoriale del bambino e la ipoacusia neurosensoriale
è la più comune forma di deficit uditivo
congenito. La sordità infantile rappresenta
quindi un grosso problema sia da un punto di vista
epidemiologico sia da un punto di vista umano se si
considerano le difficoltà di inserimento sociale,
scolastico e lavorativo che le persone ipoacusiche
incontrano nel corso della vita. Circa un bambino
ogni 1000 nati è affetto da sordità
profonda e uno ogni 300 nati presenta una sordità
di diversa gravità.
Gli Autori effettuano una revisione della letteratura
al fine di offrire un inquadramento omogeneo dei numerosi
dati epidemiologici ed eziologici; propongono, inoltre,
una nuova classificazione delle ipoacusie infantili
considerando sia l’epoca di insorgenza che gli
aspetti eziologici.
Sviluppo
del linguaggio in bambini sordi trattati con il metodo
orale
A. Bigoni – B. Piccolo – A. Tavano –
A. L. Csillaghy – F. Fabbro
11 soggetti con sordità grave o profonda (9
con sordità pre-linguale e 2 con sordità
post-linguale), di età compresa tra i 7 e i
17 anni, con intelligenza non verbale normale, figli
di genitori udenti e trattati con modalità
di riabilitazione orale (metodo verbo-tonale; Zatelli
1980) sono stati sottoposti ad una valutazione sistematica
dello sviluppo del linguaggio orale e scritto. Soltanto
i due soggetti con sordità post-linguale presentavano
uno sviluppo degli aspetti lessicali e grammaticali
nella norma. Tutti i soggetti con sordità pre-linguale
presentavano invece uno sviluppo grammaticale deficitario;
i soggetti con sordità profonda presentavano
anche un deficit nello sviluppo lessicale. I deficit
dello sviluppo lessicale e grammaticale sono stati
interpretati come effetto di una stimolazione linguistica
che non rispetta i tempi e le modalità tipiche
dei normoudenti. Le difficoltà di sviluppo
grammaticale potrebbero inoltre dipendere anche da
una selettiva compromissione di alcune componenti
del sistema neurofunzionale del linguaggio legate
all’evento patologico che ha causato la sordità.
Indicazioni
e caratteristiche dell’impianto cocleare
S. Burdo – M. De Simone – E. Cristofari
– M. F. Attardo – R. Moalli
In questo articolo viene fornita una presentazione
di carattere generale della tecnica di impianto cocleare,
che attualmente costituisce la soluzione più
all’avanguardia per la riabilitazione della
sordità, soprattutto di quella pediatrica.
Vengono inoltre confrontate le caratteristiche delle
due principali “scuole di pensiero” della
riabilitazione della sordità in età
evolutiva.
La
riabilitazione del bambino ipoacusico con impianto
cocleare: descrizione di un caso
M. G. De Iaco – L. Guerzoni – A. Trabacca
In questo lavoro descriviamo la nostra esperienza
nella riabilitazione del bambino ipoacusico con impianto
cocleare partendo da un caso clinico. L’impianto
cocleare (IC) è il primo organo bionico realizzato
dall’uomo con tecnologia elettronica, per compensare
efficacemente la sordità profonda completa
bilaterale o “cofosi”.
L’iter riabilitativo/abilitativo logopedico
specifico è finalizzato ad allenare il bambino
alla nuova percezione acustica conseguente all’IC,
favorendo lo sviluppo di rappresentazioni mentali
nuove. In particolare gli obiettivi terapeutici-riabilitativi
prevedono lo sviluppo delle principali fasi in cui
si articolano le abilità uditive.
Come già descritto da altri autori, emerge
l’importanza di intervenire precocemente nella
selezione del bambino da indirizzare all’impianto
cocleare, per consentire quanto prima il ripristino
della sensibilità uditiva e conseguentemente
il ripristino della percezione di elementi linguistici,
evitando le condizioni che stanno alla base della
disabilità comunicativa-linguistica.
Caratteristiche
linguistiche e socio-culturali della Lingua dei Segni
Italiana (LIS)
V. Volterra – E. Pizzuto – S. Corazza
Viene evidenziato come l’esplorazione delle
lingue dei segni possa contribuire sia ad un ampliamento
delle nostre conoscenze in ambito linguistico e socio-antropologico,
sia alla strutturazione di più appropriati
interventi pedagogici, in un’ottica di educazione
bilingue per le persone sorde. Le ricerche linguistiche
degli ultimi quarant’anni hanno mostrato che
queste forme di comunicazione sono vere e proprie
lingue dei segni, dotate di strutture linguistiche
analoghe a quelle proprie delle lingue vocali. Vengono
descritte alcune caratteristiche lessicali e grammaticali
della Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Il
diritto del bambino sordo a crescere bilingue
F. Grosjean
Ogni bambino sordo, qualunque sia il livello della
sua perdita uditiva, dovrebbe avere il diritto di
crescere bilingue. Tramite la conoscenza e l’uso
sia della lingua dei segni sia della lingua orale
(nella sua forma scritta e, ove possibile, parlata),
il bambino potrà acquisire appieno le sue capacità
cognitive, linguistiche e sociali.
Le
strategie di scrittura del bambino sordo: scrivere
è come parlare?
B. Arfé
Per una migliore comprensione delle strategie di scrittura
dei bambini sordi sarebbe necessario osservare il
loro processo di scrittura nelle sue fasi. Alcune
ricerche hanno dimostrato l’utilità a
questo scopo delle tecniche di facilitazione procedurale
(Bereiter e Scardamalia, 1987; Boscolo, 1990), ma
tali procedure non sono mai state applicate alle attività
di scrittura dei bambini sordi. Il presente studio
ha testato questa possibilità. Sono state analizzate
le strategie di scrittura utilizzate nella produzione
di testi espositivi da 9 bambini sordi e 9 bambini
udenti (dalla terza elementare alla seconda media).
Facendo uso di una tecnica di facilitazione procedurale
è stato osservato come questi bambini durante
il processo di scrittura passavano dalla generazione
del contenuto alla sua trascrizione. Ogni bambino
è stato visto tre volte e testato durante la
produzione di tre testi. I bambini sordi ed udenti
hanno utilizzato durante la produzione del testo la
stessa gamma di operazioni cognitive, ma sono emerse
alcune differenze tra i due gruppi considerando l’effetto
dell’esperienza scolastica sull’uso di
queste strategie. In particolare, l’elaborazione
sembra essere la strategia prediletta dai bambini
udenti di scuola media, mentre i sordi sembrano utilizzare
strategie di scrittura meno sofisticate.
|