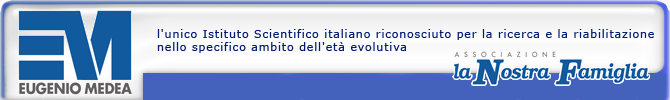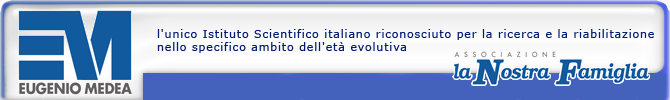|
Ritardo mentale grave: vogliamo finalmente andare avanti?
M. Cannao
Facendo riferimento al volume scritto 25 anni fa in
collaborazione con Giorgio Moretti sul tema del ritardo
mentale grave, l’Autrice prende in considerazione alcune
delle possibili linee di sviluppo di questa tematica,
alla luce dell’evoluzione delle conoscenze e delle nuove
risorse tecnologiche oggi disponibili. In particolare,
il contributo riguarda gli apporti che potrebbero derivare
dall’AI (Artificial Intelligence) nelle sue diverse
applicazioni, dalla Neuropsicanalisi e dallo studio
delle emozioni impostato in chiave moderna: da questi
tre settori è infatti possibile trarre spunti che consentirebbero,
se adeguatamente sviluppati, di costruire nuovi modelli
interpretativi del ritardo mentale grave e nuove possibilità
di intervento per coloro che ne sono affetti.
Viene infine sottolineata l’importanza della dimensione
antropologica nella presa in carico del grave ritardato
mentale, intesa come premessa di qualunque intervento
riabilitativo e come necessaria salvaguardia dei diritti
umani di queste persone.
Costruzione dell’identità nel grave disabile cognitivo
nell’ottica della Medicina Basata sulle Narrazioni
C. Ruggerini, F. Villanti, A. Solmi
La Medicina Basata sulle Narrazioni (MBN) è un orientamento
culturale che si affianca, da pochi anni, a quello,
assai più noto, della Medicina Basata sulle Evidenze.
È’ un orientamento che tenta di comprendere le persone
a contatto con i sistemi di cura nei loro particolari
contesti e risulta quindi appropriato alle condizioni
croniche in cui il contributo della Medicina non può
essere finalizzato alla guarigione ma si orienta al
fine della Qualità della Vita. Nelle persone disabili
e senza linguaggio, soprattutto se in presenza di Disturbi
Mentali sovrapposti, l’intensità dei trattamenti o delle
terapie richieste può essere tale da indurre nel sistema
di cura la attribuzione di un unico ruolo di malato.
L’orientamento della MBN, che suggerisce attenzione
agli eventi della quotidianità, aiuta a riscoprire la
persona oltre l’insieme delle sue disfunzioni. Vengono
riportate 4 narrazioni relative a ospiti di una Residenza
per persone con disabilità intellettuale grave e Disturbi
Mentali associati; degli stessi ospiti viene riportata
una descrizione psichiatrica funzionale alla scelta
dei trattamenti e delle terapie mediche. Si evidenzia
il contributo delle narrazioni delle esperienze quotidiane
non solo al riconoscimento della unicità e del valore
dell’individuo – e quindi alla costruzione della sua
identità – ma anche alla valutazione degli esiti degli
interventi medici e al rafforzamento della alleanza
tra sistema curante e familiari.
Attaccamento ed emozioni nel disabile psichico adulto
G. Cristiano, G. Foresti
Negli ultimi decenni la letteratura relativa alla persona
con ritardo mentale ha registrato un notevole incremento.
Tale aumento di interesse verso questa tematica è sicuramente
legato al supporto legislativo che è alla base dell’integrazione
della persona con ritardo mentale all’interno dei diversi
contesti sociali e al crescente numero di esperienze
che si sono via via accumulate. Tuttavia esistono ancora
delle lacune, una delle quali riguarda le caratteristiche
comportamentali nella persona con ritardo mentale, la
dimensione psicopatologica e le sue possibili cause.
La presente ricerca si inserisce nell’ambito degli studi
sull’attaccamento e sul ruolo delle emozioni nella psicopatologia
associata al ritardo mentale. Si vogliono esplorare
i possibili rapporti tra il legame di attaccamento e
la psicopatologia nella persona con ritardo mentale,
tra l’attaccamento e i processi metacognitivi e quanto
questi svolgano un ruolo centrale nella regolazione
delle emozioni e nei disturbi psicopatologici. Nello
specifico ci si chiede se il legame di attaccamento
nel soggetto con ritardo mentale possa essere considerato,
così come nel soggetto sano, un fattore di rischio o
di protezione all’interno di una cornice interpretativa
che considera importanti altri fattori relativi: dalle
variabili genetiche, al temperamento, al contesto familiare
e sociale e a eventuali avvenimenti destabilizzanti
nel corso dello sviluppo. Pur nella consapevolezza del
non facile compito di voler approfondire le competenze
emozionali e i pattern di attaccamento nel campione
individuato, si ritiene interessante approfondire questi
aspetti per meglio osservare eventuali differenze, ma,
più ancora, le analogie con il soggetto che non presenta
un deficit cognitivo.
Il ruolo dell’inconscio nella riabilitazione del ritardato
mentale adulto
F. Lolli
L’articolo propone una riflessione sulla necessità di
introdurre, all’interno del discorso riabilitativo sul
ritardo mentale, la considerazione di una variabile
generalmente ignorata o sottovalutata: l’inconscio.
Ciò che viene messo in risalto è l’assoluta pertinenza
di tale inclusione dell’inconscio nel campo riabilitativo,
e questo per almeno due ragioni: la prima di natura
ideologicoculturale, la seconda più di carattere clinico.
Da un lato, negare nella persona affetta da ritardo
mentale la presenza dell’inconscio equivale a negarne
lo statuto di soggetto; in altre parole, ad affermare
la sua collocazione in una sorta di subumanità nella
quale la complessità della persona si appiattisce sul
livello del bisogno e dell’istinto. Dall’altro lato,
negare la presenza dell’inconscio vuol dire semplificare
in maniera superficiale l’approccio al paziente, non
riconoscendo alle sue azioni quello spessore e quella
profondità che solo il lavoro dell’inconscio assicura
e che, pertanto, vanno tenuti in conto all’interno del
rapporto riabilitativo, per comprendere fenomeni, reazioni
e comportamenti altrimenti inesplicabili.
L’identificazione proiettiva nell’adulto con ritardo
mentale
P.G. Curti
Nel quadro del trattamento psicoterapico rivolto all’insufficiente
mentale adulto lo specifico intervento della psicanalisi
necessita, prima di tutto, di reperire un quadro metapsicologico
che permetta di sostituire i concetti cardine di transfert
e interpretazione con altri che possano assicurare un
nuovo setting di pensiero per garantire l’ascolto nei
confronti dell’insufficiente mentale. È nel concetto
di identificazione proiettiva1 che si può promuovere
un nuovo orientamento della psicanalisi in questo spazio
clinico. L’identificazione proiettiva diventa l’orizzonte
comunicativo in cui il processo primario si può articolare
in direzione del percorso simbolico. Recuperare e ascoltare
le diverse modalità in cui il soggetto insufficiente
mentale adulto attiva la identificazione proiettiva
in direzione degli educatori, psicologi, psichiatri
è un canale che permette di promuovere nuovi progetti
educativi e terapeutici.
Psico(pato)logia del ritardo mentale
G.L. Mansi – M. Molteni
Il Ritardo Mentale (RM) rappresenta una organizzazione
svantaggiosa della personalità che aumenta in maniera
significativa il rischio di sviluppare un disturbo psicopatologico.
La presenza di un RM e di un disturbo psicopatologico
definisce una condizione clinica particolarmente complessa,
in cui coesistono e si influenzano reciprocamente elementi
cognitivi, psico(pato)logici, fisici e socio - ambientali.
In questo lavoro di riflessione clinica abbiamo cercato
di descrivere alcune caratteristiche della psico(pato)logia
del disabile psichico. Siamo partiti dall'assunto che
la comprensione della psicopatologia è possibile solo
se si approfondiscono le conoscenze sulla psicologia
del disabile psichico, superando una diffusa tendenza
a considerare soprattutto gli aspetti problematici del
comportamento, come fossero privi di una mente che li
sottende, nel tentativo di comprendere come pensa un
soggetto con Ritardo Mentale.
Auspichiamo che la nostra posizione osservativa favorisca
la costruzione di un approccio empatico,di una maggiore
comprensione psicologica e di una migliore personalizzazione
dei programmi di cura.
Psicofarmacologia del ritardo mentale
C.M. Cornaggia – F. Amidani – G. Duranti – A. Mascarini
Da alcuni anni il termine Ritardo Mentale è stato opportunamente
sostituito con quello di Disabilità Intellettiva (DI)
nel tentativo sia di diminuire il pregiudizio e lo stigma
ad esso collegati che di utilizzare una terminologia
più appropriata all’oggetto. Il primo aspetto che è
necessario approfondire riguarda la reale esistenza
di una psicofarmacologia della DI. Il trattamento psicofarmacologico
della DI è necessario solamente quando compaiano alterazioni
psicopatologiche, rappresentate soprattutto da disordini
del comportamento, tali da necessitare la cura mediante
assunzione di farmaci. La scelta del trattamento si
basa pertanto non sulla diagnosi di DI in sé, ma sui
sintomi psicopatologici che possono eventualmente associarsi
ad essa. Tali sintomi, frequentemente osservati nei
soggetti con DI, possono in realtà essere espressione
di diverse condizioni sottostanti. Al contrario, in
alcuni casi possiamo invece parlare di una vera e propria
sindrome psichica associata a DI: uno studio epidemiologico
recente rileva infatti che il 40,7% dei bambini tra
i 4 ed i 18 anni con disabilità intellettiva soddisfa
i criteri di almeno un disturbo mentale. Le caratteristiche
cliniche delle sindromi psichiatriche che si manifestano
nei soggetti con DI non differiscono da quelle che si
presentano nei soggetti senza DI e pertanto anche il
trattamento sarà pressoché lo stesso. Purtroppo la classe
di farmaci ancora maggiormente usata è quella degli
antipsicotici, ma sta crescendo anche l’interesse per
antidepressivi e antiepilettici. Da un’analisi critica
della letteratura appaiono scarsi gli studi clinici
controllati e pertanto la scelta del trattamento appare
spesso guidata da dati aneddotici e dall’esperienza
clinica
del singolo medico.
I servizi per la salute mentale nella Disabilità Intellettiva
G. La Malfa
L’articolo sottolinea, dopo una disamina di alcuni nodi
problematici del rapporto disturbo psichico-disabilità
intellettiva, la necessità di promuovere la salute mentale
e la qualità di vita nei soggetti con disabilità intellettiva.
Riporta quindi l’esperienza di un Servizio creato a
tale scopo, operante presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Careggi in Firenze. Auspica infine una maggiore sensibilizzazione
delle Istituzioni per le politiche sanitarie rispetto
al tema trattato.
Ruolo del dipartimento di Salute Mentale nella cura
dei soggetti con Ritardo Mentale
R. Gadaldi – G. Colombo
L’articolo si propone di affrontare le problematiche
dei servizi psichiatrici per adulti nella gestione dei
pazienti affetti da ritardo mentale in comorbilità con
manifestazioni psicopatologiche.
Il Ritardo Mentale, così come i Disturbi afferenti alle
Alterazioni Globali dello Sviluppo Psicologico, si costituiscono
come “aree nosografiche di confine” e il margine tra
bisogni sanitari e socio-assistenziali non è ben delimitato.
Fattori di tipo clinico, dinamiche famigliari e necessità
di integrazione tra le diverse agenzie di tipo sanitario
e sociale coinvolte, rendono auspicabile la formulazione
di percorsi di cura e di modalità di presa in carico
più specifiche per questi pazienti.
L’esperienza del gruppo di collegamento che vede coinvolti
operatori delle équipe sia delle Unità Operative Psichiatriche
per adulti (UOP) sia delle Unità Operative NeuroPsichiatriche
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) ha evidenziato
in questi anni l’importanza di condividere un linguaggio
clinico e diagnostico comune e di trovare, con la formulazione
di Percorsi Diagnostico Terapeutici, una risposta più
efficace ed efficiente per questi pazienti e per le
loro famiglie.
|